La crisi della krísis.
Spunti di riflessione sulla crisi economica e sociale nel 2025
La crisi sociale ed economica sta diventando sempre più un tema di riflessione all’interno della nostra società. Si approfondisce il tema della crisi sotto il profilo economico, culturale, psicologico e sociale anche attraverso la ricostruzione storica dell’evoluzione del Welfare.
Il concetto di crisi viene spesso contrapposto al concetto di crescita quasi a significare che la crescita di un Paese, o di una persona, prescinde dalle crisi che si presentano durante il percorso di sviluppo. Credo che, per superare la crisi, sia necessario ripartire innanzitutto dall’etimologia della parola crisi (dal greco krísis – κρίσις) che ha il significato di scelta, decisione; che non va interpretata come sinonimo di “malattia acuta” che, in questo particolare periodo storico, sta diventando “cronica” (la crisi che stiamo tutt’ora affrontando ha avuto origine nel 2008 e la recente pandemia da Covid-19 ha influito notevolmente sul benessere socio-economico nazionale).
Ogni crescita, evoluzione, sviluppo sottende la presa di decisioni, il compimento di scelte e l’assunzione delle relative responsabilità, in un binomio crescente di causa – effetto. In questo cambio di prospettiva, quindi, crisi e crescita non vanno considerati come elementi agli antipodi, ma, bensì, come due componenti distinti facenti parte dello stesso processo.
Per evitare di ripercorrere delle tappe già considerate, e su cui si è già abbondantemente dibattuto, proverò a tentare di sollecitare alcune riflessioni partendo da prospettive diverse del concetto comune di crisi e crescita.
Nella contrapposizione fra i termini “crisi” e “crescita” appare interessante la prospettiva di Luca Ricolfi che, ne “L’enigma della crescita”, affronta l’argomento della crescita partendo da un’analisi, principalmente a carattere economico, che valuta, come fattori cruciali, il capitale umano, gli investimenti esteri, le istituzioni e la tassazione. A questi fattori aggiunge il benessere, evidenziando l’aspetto che più un Paese è ricco e meno facilmente cresce. Ciò accade probabilmente per diverse ragioni, ma ritenendo soprattutto che l’espansione economica generata dagli scambi di mercato ha storicamente permesso la crescita del potere statale e di conseguenza la crisi del capitalismo medesimo.
Per certi versi, tale principio è emerso anche nelle politiche sociali con l’attuazione del New Public Management ed, in particolare, della teoria dei quasi-mercati, che prevedeva l’erogazione dei servizi attraverso logiche di mercato, lasciando però allo Stato un duplice compito: da una parte, regolare il sistema dell’offerta dei servizi attraverso il sistema di accreditamento (al fine di garantire la qualità) e, dall’altra, sostenere la domanda, finanziandola attraverso l’erogazione di titoli di acquisto (c.d. voucher). La logica sostanziale sarebbe stata quella di promuovere la libertà di scelta in un sistema di offerta, che sarebbe divenuto così concorrenziale, garantendo però anche ai soggetti fragili di avere accesso ai servizi attraverso l’utilizzo dei titoli di acquisto.
Utilizzando lo spunto di riflessione proposto da Ricolfi, appare, a questo punto, chiaro che la logica dei quasi – mercati nella gestione della “cosa pubblica” sortisce, come effetto a medio e lungo periodo, quello di limitare l’autonomia e la capacità d’innovazione della società civile, poiché la rende “dipendente” dal sostegno pubblico, che accresce il suo potere attraverso il sistema di accreditamento ma che, al contempo, è in difficoltà a garantire l’erogazione dei titoli di acquisto.
Il servizio sociale si è storicamente occupato della crisi e, nella giornata mondiale del servizio sociale 2014, sono state individuate cinque strategie per il superamento della precarizzazione e del depauperamento delle condizioni di vita di molti individui e famiglie, al fine di promuovere una crescita sostenibile. Tali strategie/obiettivi consistevano sinteticamente nel:
1) promuovere l’uguaglianza e l’equità;
2) aiutare le persone a vivere in modo sostenibile;
3) costruire partecipazione delle persone;
4) favorire lo sviluppo di comunità che hanno cura dei propri membri;
5) promuovere il rispetto delle diversità, la comunicazione e la relazione tra gli individui.
Tali strategie/obiettivi rientrano nel ruolo e nelle funzioni riconosciute alla figura dell’assistente sociale che, nell’attuale contesto storico e anch’essa assorbita dalla crisi in quanto “vittima” dell’attuale situazione del mercato del lavoro che tende ad una precarizzazione e frammentazione, vive una situazione di discontinuità nei Servizi Sociali Professionali (come si evince, peraltro, nel Documento del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali sui punti di criticità delle condizioni sociali del Paese e dal documento “L’assistente sociale “liquido” e la voglia di comunità: una ricerca – azione sulla condizione di precarietà – disoccupazione degli assistenti sociali in Piemonte”).
È da sottolineare come i punti individuati nella giornata mondiale del servizio sociale 2014, siano poi stati ripresi negli anni successivi sottolineando ulteriormente l’importanza dell’uguaglianza, dell’inclusività, delle relazioni umane e di una crescita sociale in armonia con l’ambiente come previsto anche dal Codice Deontologico dell’assistente sociale.
Emerge, da una lettura dei dati forniti dall’indagine di Cittalia e SWG intitolata “La Repubblica dei Comuni nel XXI secolo” (2013), la percezione che i cittadini hanno della crisi, poiché l’83% degli intervistati ritiene che l’Italia sia in una fase di regressione che durerà ancora a lungo (88%). Emerge, inoltre, che, dal 2009 al 2013, è pressoché raddoppiato il numero di coloro che si sentono danneggiati dalla crisi e che si sentono investiti dalle preoccupazioni crescenti in merito alle necessità legate alle spese primarie (ad esempio preoccupazione per pagare le bollette, le spese mediche ed alimentari). Dall’analisi effettuata si evidenzia anche l’aumento della preoccupazione di perdere i risparmi accumulati e di non riuscire a mantenere lo stesso tenore di vita (rispettivamente 43% e 39%). Appare evidente come la preoccupazione di perdere il posto di lavoro o i risparmi accumulati, di non avere i mezzi per curare se stessi o un familiare possono essere considerati sintomi dell’aggravarsi della situazione attuale e dell’affermazione di una condizione di povertà che tende a diventare persistente e duratura.
Tale percezione non sembra essersi modificata nel tempo:Il rapporto CIDA-Censis del 2024 rivela che il 75% degli italiani prevede un peggioramento delle condizioni di vita per le future generazioni ed anche il rapporto annuale 2025 Istat fa emergere che “La povertà assoluta coinvolge nel 2023 l’8,4 per cento delle famiglie residenti (2,2 milioni di famiglie e 5,7 milioni di persone), in particolare famiglie con figli, giovani, stranieri e residenti nel Mezzogiorno. Rispetto al 2014, l’incidenza è aumentata di oltre 2 punti percentuali a livello familiare e di 2,8 punti a livello individuale”.
Da questo brevissimo spaccato attraverso la politica economica, sociale, del mercato del lavoro e della percezione dei cittadini della crisi, è possibile sollevare una serie di questioni sulla sostenibilità economica e sociale dell’attuale sistema di riferimento.
Credo che il rischio, in questo momento storico, sia quello di una deriva dirigista in ogni settore, in cui un approccio emergenziale e contingente finisca per ridurre, di fatto, la spinta innovativa ed il confronto che dovrebbe alimentare una vera modernizzazione del sistema di welfare. Credo che la “nostra crisi”, quindi, non sia dettata da una sorta di virus esterno che ci ha colpito mettendo a repentaglio la nostra “salute”, ma che piuttosto vada ripensata come un momento di riflessione sulle scelte fatte e su quelle da effettuare, cercando di uscire dalla logica dell’emergenza e della delega perché nell’idea di crisi è incluso il concetto di problema e quello di superamento del problema.
Le scelte, le decisioni e le azioni credo debbano essere frutto di una riflessione, meglio se interdisciplinare e non autoreferenziale, che tenga conto delle difficoltà e delle potenzialità esistenti o incrementabili con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile i costi sociali genericamente intesi e senza sottovalutare il principio di autodeterminazione delle persone, così come previsto anche dal nostro codice deontologico.
Ecco spiegato il titolo “La crisi della krísis”.
“Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé il pericolo, dall’altra l’opportunità.
Capovolgete la moneta. Non perdetevi l’opportunità di emergere da questa crisi più forti e più intelligenti: dei sopravvissuti migliori.” Jeffrey J. Davis (avvocato).

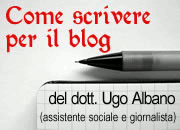
Nessun commento Leave a comment »
No comments yet.
Leave a comment